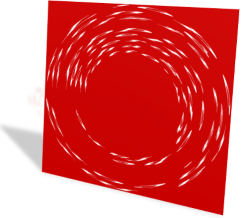Le insaziabili voci colluse scandiscono i riflessi che vanno scemando l’oro dei dieci capelli appena ottenebrati dal vanto ligneo incarnato tra la notte e il giorno sui sette colli. Oltre la digradante prospettiva umana l’uomo coltiva, senz’alcuna sosta, la fiamma ruvida che ad aprile porterà i suoi frutti nel mai abbandonato orto, lì dove il sonno non giace e la carne non ha più dimora. La desolazione conquista l’abominio della salita più ingrata verso la ruota invertita e inchiodata dal cranio. Non v’è compassione tra gli alberi, tantopiù tra le foglie mentre dissecca l’erba e la tragedia muore. Così come non v’è comprensione tra i popoli, non v’è lingua che al suo palato taccia più volte il dolore udito, visivo. No, malgrado il ventunesimo secolo manifesti la sua volontà di non abdicare a favore dei millenni sdatati un abisso d’acqua, dalle sette braccia potenti, spinge al collasso le circa duecento balenottere oranti esecuzioni di massa con l’ossigeno sopra le vertebre cervicali a fare da vittima e testimone, con sconfinato suono. Il sole mortifica la terra e quanto essa contiene, i mari dunque, magma sulle città in estinzione. Fugge. Fugge perché il momento è giunto. A compiere il compiuto è la doglia, il deserto, il pianto. E dodici stelle, alte quanto lo scomponimento imploso del caos espanso, erte sui cieli della lapide della menzogna e del seno intriso di vittoria, coprono la vergogna di nebule, costellazioni, pianeti e mondi. E sette ceste, con cinque pani e due balenottere orfane di fondali e traiettorie, moltiplicano la siccità di uno stupore smagrito negli occhi futuri di chi non è più. E tu, bambino, apri la porta al tuo sorriso che era avanti a te già prima di te.
(07/10/2021)