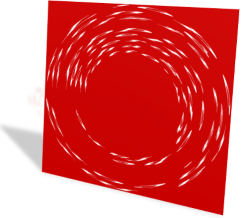Così dice Dio, il mio Dio, il Signore degli eserciti, nella dodicesima ora del trentunesimo giorno del decimo mese del ventitreesimo anno della duemillesima età. Siedi, figlio dell’uomo, e scrivi un lamento con le parole che sto per farti ingoiare. Poi vomitale tutte, una dopo l’altra, in questo tempo che è il mio tempo giacché altri non ve ne sono mai stati né ve ne saranno. E non piangere su di esse, perché sono parole di vanto e di vendetta dalle quali scaturiranno esondazioni di condanna.
Da dove mi provenne
questo nome
che pesa l’appartenenza
di una moltitudine di popoli
sul mio collo?
Quale bilancia mi fu affidata
perché io frodassi
tra i due piatti
l’enorme giustizia
che giammai fu mia?
Io vivo la pena che mi spetta.
Unica certezza
in questo mare di trappole
e di vendette che mi circonda.
Eccomi.
Sono colei che della miseria
ne ha fatta una collana
e che non recide
i suoi grani di sventura.
Per me oggi
esiste un solo tempo:
quello della morte,
del definitivo distacco
del mio respiro alla mia angoscia.
Ho calpestato uomini
come fossero erba dissecata;
li ho fatti sparire
al risveglio delle lucciole
e delle cicale.
Ho tradito i miei pari,
i miei schiavi,
ma prima ancora
ho tradito la vita
(tempo che nemmeno mi percuote)
e con essa
Colui che mi diede anelito,
speranza e terra.
Ho tanto odiato
da essere provata
io stessa nell’odio
e la mia condizione ultima
è peggiorata fino al delirio.
Oh, la pena passa dinanzi ai miei occhi
mi sorride e fugge via!
Nemmeno lei
nutre pietà per me,
nessuna compassione
oggi mi spetta.
Vorrei piangere lacrime di madre
ma io non lo sono mai stata.
Vorrei anticipare
come una sentinella
il fascio selettivo dell’aurora
ma non mi compete:
non è conveniente
ad una prostituta
lasciarsi trovare ebbra di sogni
tra i sentimenti della luce, no.
Ancor più perché le tenebre
sono state la mia tenda,
la mia festività assordante,
la mia canzone di condanna.
Io sono colei
che ha avuto figli e figli,
amanti e amanti.
E sono dunque pure
colei che li ha visti crescere
come tanti polloni bastardi
e se ne è rallegrata.
Ho coltivato oro arabo
ricavandone zizzania.
Ho seminato la mia rabbia
nell’altrui vigneto
e si è mescolata tra i rovi e i pruni.
Eccomi.
Incarno la miseria
e me ne vanto,
poiché questa solo m’è rimasta:
una collana stretta in collo
che al momento giusto
saprà diventare cappio.
Fenderò così il mio capo
per sempre?
Credevo di avere capelli
colorati di gloria
e invece mi ritrovo
con la nuca scoperta
mentre cresce solo
la mia vergogna
e neanche me ne accorgo.
Ho percosso la mia dignità
e questa mi ha posto la sua guancia.
Sì, mi ha concesso d’infierire
ed io mi sono ritratta dal bene.
Ho veduto i miei figli morire
per le mie malvagità
e me ne sono fatta una ragione,
una collana ancora più grande.
I miei amanti
mi hanno spogliata e usata
come si usano gli stracci
per togliere la polvere:
ma la polvere non si consuma
ed io non sono andata via.
Al mio seno si sono avvelenati
uomini e lattanti;
le mammelle degli sciacalli
risultano più mielose delle mie.
Cosa mi resta da fare, oggi?
Se scappassi dalla mia miseria
troverei il cappio della dignità
a far da garante per la giustizia.
Se fuggissi verso la ragione
troverei Colui che in silenzio
sembra non osservare nulla
e che invece tutto ciò
mi ha arrecato, impietoso,
dimenticandosi del mio nome,
del suo servo, della sua alleanza.
E resto inutilmente fredda,
ferma in un ghiacciaio
di rimorsi e di rimproveri
che mi provocano prurito alle ossa
in questo tempo di morte,
come un uovo di pellicano
soggetto alla legge della foresta
e abbandonato.
Quale improvviso dolore
si sta affacciando in me,
alla mia bocca.
Ma non sono lacrime, no.
Sono soltanto memorie.
Sono le memorie di quelle parole
che avrei dovuto dire
e che mai dirò.
Perché io sono la non più amata
e la dimenticata.
La più deliziosa delle nazioni,
splendore di tutta la terra,
stracciata come rotolo di un libro
che non ha più scrittore.
E nel mio giaciglio resto,
con la follia di queste mani
intrappolate alle mie due collane,
di notte in giorno,
di grano in grano.
(31/10/2023)