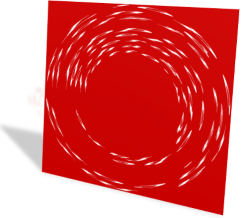Di mezzo a voi,
come se a logorare
il tormento delle vostre piaghe frante
null’altro fosse che un’alba filante,
tanto snella quanto inaccessibile.
Anime.
Queste macere pietre
che sudano su di un’arena immobile
la quale vuota il suo contributo emotivo,
viscerale, lì, verso la boa di mezzo,
dove come un cedro appassito
ancor si leva il vessillo squarciato della terra.
E i sorrisi, le catene,
i volti appesi al filo illogico della resa.
Quanto,
ancora quanto misero e caduco
è il cappero slegato dalla coda dell’infante.
La leccornia è esaudibile
al ventre delle magre vacche,
snelle più di quell’alba filante.
Eppure esse sono accessibili,
sono le metamorfosi dell’attesa
che si lasciano penetrare dall’umana superbia,
dalla casta vanagloria,
da matrona vanità.
Il tempo della locusta
è reindirizzato verso il putrido sapere,
quello che lascia sfiorire
il verso afono della mandragola
nel campo abietto delle barbabietole
e delle risaie.
Un’altra direzione stabilisce
la dimensione del giorno appena trascorso
in una trasfigurata volatilità
dell’orma dei cinghiali
dal lamento storpio e amatoriale.
In questo istante
dal basso incedere delle ombre,
quando la morte attecchisce
sulla reiezione della iraconda speme
anteceduta in spasmi vettoriali
di un’imbalsamata quiete,
anche il passo falso del bisonte
è trascurato nella foresta.
Ora,
ora dalla tortura blu e nera.
E nei miei occhi la pena è libera,
libera di riservarsi un regime logico
di trasmissione dell’ira
nei campisanti delle insudiciate tregue
di un dolore affettato
dai macellai delle anatomie del genere,
ove il caviale più pregiato
viene ceduto sempre più spesso
per frivole sostanze chimiche
affinché le anestesie cerebrali
simulino le più elevate alchimie sferiche
tra le catacombe mediterranee
rilevate ai nuovi contraffattori
di questi tramortiti paesi.
Un palazzo,
io afferrerò con il mio solo olfatto
la traiettoria del monta-persone declassato
svelando ai popoli agonizzanti
la progenie di tutte le caserme.
Una connessione falsificata
dalla invalidità della norma e della regola
che si mimetizza
tra le nazioni delle medesime nazioni
come un poligono pentagonale,
un laccio che non trova pace
nemmeno quando vinta ormai è la preda.
Eppure il dardo è teso,
l’aria è immobile al pari di quell’arena
che vuota nel mare dell’imbelletto
le surrogate emotività
del collettivo lasciar scorrere,
lasciar colare.
E la pietra livida è rapida
verso la sua meta.
Dodici salti e dodici immersioni
sopra delle acque
che si ricompongono dopo tanta,
troppa miseria.
Lascerò il mio cuore transumare
sui vecchi colli della umiliazione umana
amplificati dal riverbero della stoltizia
e della fandonia
ancora per questa ora,
ancora per questa flebilissima nota
che rende imperfetto il pentagramma
delle notturne scale,
smussate in filarmoniche dai dissapori uniti,
così ben spartite tra i più filantropi quartieri.
Sì,
zone infette dalla barbarie di un virus
ormai senza più canizie,
lì dove la lotta è un gioco di due,
tre carte forse,
e dove il baro è sempre in turnazione di veglia
per la ghiotta defraudazione
di una massa impotente,
colpevole, con ogni probabilità,
di non voler stare al gioco
quando va’ la messa in scena
del genocidio di piazza.
L’assurdo giogo
della formula contraria
e della sempre più mercenaria materia
pone catene su catene al collo dei bambini,
gli innocenti più grandi.
Ecco.
Io non pronuncerò atti,
non promulgherò leggi,
non emenderò vaticini
in quest’ora morbida e arresa, ormai,
al seno inturgidito del mio sangue.
Di mezzo a voi,
come se a logorare
il tormento delle vostre piaghe frante
null’altro fosse che un’alba filante,
lascerò brillare
una costellazione di cordoglio,
di commiserazione,
di condanna,
sotto un cielo acceso dalla vile paura
che tra le mie impronunciabili labbra
è già divenuta paglia,
una porzione sterminata
tanto snella quanto inaccessibile.
Anime. Anime?
(15/03/2022)