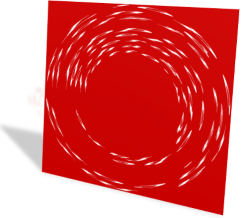Dovrei schiarire,
invero, le tue nudità,
le realtà estreme e non ultime
che hai definito
nella membrana delle altrui idee,
e per altrui
null’altro si può intendere
che la scoperchiata nervatura
riaddensata tra i non popoli
preda, ormai,
dei monsoni di un cielo
che ad aperte cataratte
vomita pioggia cadaverica,
frutto di un raccapriccio storico
e di un bailamme catalizzato
dalla distonia del secolo,
a meditabonda
e rielaborata umana miseria.
Ma non lo farò.
Lascerò i tuoi laceri panni,
le tue zuppe vesti
a indebolire le postume condizioni
delle non mie prospettive
tutte ancora da fondare.
Ecco.
Io non ti curerò più
come un pastore il suo gregge,
poiché la tua transumanza
ha colmato la misura
dei tuoi predecessori superandola.
Non agnello né capro
sei diventato per me:
sei una non bestia.
Eppure il tuo capo
è investito di nuove corna
quanti sono i regni superstiti
della voce che ti condanna,
infausta,
e che al tempo ti acclama
come suo re e suo signore,
suo signore e suo aguzzino,
nella miscredenza delle vocalità superbe
che suolerebbero magnificare
la tua assenza.
Non hai zanne
per infastidire i tuoi simili avversari
poiché la tua lingua
possiede tanto di quel veleno
da rovinare mondi paralleli e prossimi.
La periodicità dei tuoi battiti cardiaci
conoscono le impari partiture
della sclerosi dorsale,
della lebbra invernale
che il tuo pelo avvolge
con avara parsimonia
nella brutale stagione della mia collera.
Hai nelle zampe del tuo petto
altere vene
atte a condensare
unioni di germi nocivi
che fatalmente
hanno già pronosticato
la tua recessione definitiva
dal possedimento dei beni non primevi,
catalogati tra le più disparate,
blasfeme dimensioni
di lavici grugniti dal vezzo immobile,
membra sovrane del tuo livore.
L’incesto che ti rende favorito
nel predominio di una corsa
che non a me appartiene
è l’ultimo accordo che scalerà,
dal tuo piacere immondo,
non seme ma bava,
bava per designare
la giuntura unica della putrefazione
che attende il tuo ghigno
mai stato così beffardo,
poiché quanto più l’orgoglio
avverte il pericolo
di una dipartita infame
tanto più la superbia
sale sulla cattedra della vile apostasia,
neanche riguardasse
un vilipendio alla ossessionabile cordialità,
con il sangue alle zampe
sempre più stroppiate
che urla il mio nome
per opera di quella bestemmia
che ti vede solo,
nel panteon della regredita reliquia
scavata nell’adiacente profondità
della peste che ti solidifica e t’impura,
inutilmente principe di una conoscenza
che schiavo e non servo
ha reso il tuo cervello
divenuto muscolo di un secolo errabondo
il quale muro dopo muro,
passo dentro passo,
tempo dopo tempo,
atto dentro atto,
non ha più parola
e non ha più timore
poiché la sua speranza è morta
poco prima
che di luce abbondantissima
lo invadesse il sole.
E tu, uomo,
che fingi con effimera bontà
d’essere una ripartizione
di quel calore
proiettato dagli emisferi rifrangenti
che solo a me appartengono,
di che ti imbelletti, dunque,
se non sei né capro né montone?
Hai sollevato il tuo mento
sopra la carezza dell’armonia
e il tuo occhio, il tuo occhio
non si è voltato indietro,
lì dove tutto è preparato
per la lavanda della corolla,
dell’iride, della retina e della pupilla,
a sollevate braccia e a calpestata idolatria,
a nettata tirannide.
(18/05/2022)